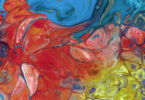Uno scrittore altissimo, voce solenne dell’estremo novecento italiano, spesso trascurato dai programmi scolastici e relegato al godimento di pochi.
Chi avesse incontrato Gadda, a Milano o a Roma, sarebbe stato colpito dalla immagine di un vecchio signore: serioso, quasi schivo. Immerso in pensieri tenebrosi, come il suo carattere, o intento a misurare i passi che compiva. Accorto a non incrociare sguardi altrui e pronto a rincasare frettolosamente, come un topo che si salva. I suoi conoscenti e amici dicevano che uscisse solo due volte al mese, che il pessimismo si era con il tempo acuito sino a tramutarsi in una vera e propria nevrosi, un “male oscuro”.
Milano e Roma furono le città della sua vita. Nella prima nacque e studiò, nella seconda, a ottant’anni, rese l’anima a Dio (anche se non ci credeva) in punta di piedi e senza fragore. Era scontroso, ermetico e concedeva a pochi il privilegio della confidenza. I fortunati che riuscirono ad oltrepassare la sua solida corazza, scopersero un uomo sarcastico, umoristico, pronto a dare di piglio al suo sterminato vocabolario. Altrettanto solerte a rendere onore ai meritevoli e indifferente verso coloro che millantavano credito. I millantatori non gli andavano a genio, soprattutto perché credevano di essere migliori degli altri. «Non vogliate nulla al di sopra della vostra capacità: Vi è una cattiva falsità presso coloro che vogliono al di sopra delle loro capacità». Amava ripetere a mo’ di citazione le frasi proferite dalle grandi menti, quella poc’anzi riportata è di Voltaire.
Molto vicino alla famiglia alto borghese da cui proveniva, essere primogenito per lui rappresentò sempre una grande responsabilità, la sorella in una intervista del 1972 ebbe modo di raccontarlo. Il Gadda bambino era sveglio, allegro, un monello vivace tant’è che qualche scapaccione dal papà non tardò ad arrivare, come lui stesso ricordò. Alla madre non perdonò mai la fissata disciplina a cui lo sottopose. Questa disciplina prevedeva studi di ingegneria, verso i quali non si sentiva portato. Al Politecnico di Milano si fece comunque onore e conseguì la laurea. Il disegno familiare aveva delineato per lui la professione di ingegnere, la svolse malvolentieri ma con un grande senso di responsabilità.
Intanto la passione per la letteratura, maturata al liceo, non si spense. Parallelamente agli studi di ingegneria lesse avidamente i classici, soprattutto latini. Senza dimenticare Shakespeare, la cui immensa e ineguagliata opera poetica divenne centrale nella sua attività di scrittore.
Uno dei suoi crucci più fastidiosi fu quello di essersi affrancato tardivamente dall’abominevole professione, avrebbe voluto seguire studi umanistici e vivere grazie al sommo talento di cui disponeva. Poté farlo solo in età matura dopo la vera consacrazione.
Carlo Emilio Gadda appartiene a quella schiera di scrittori che segnano un’epoca, la plasmano e la superano. Nelle sue opere ha nominato la vita come a pochi capita. I più sono narratori che raccontano storie: belle e profonde e affascinanti. Lui invece ha dato nomi alle cose, alla vita, ai sentimenti, alle emozioni. Ha visto quello che gli altri hanno immaginato di vedere, ha percepito quello che altri hanno sognato di percepire. E questo capita solo ai grandi scrittori, i quali posseggono il dono e la responsabilità di comporre l’alfabeto emozionale che penetra in noi senza rumore. Appartiene letterariamente alla famiglia di Joyce, Proust e Celine; noi abbiamo la fortuna di avere un grandissimo che ha utilizzato la nostra lingua come nessuno ha mai fatto.
Questo strumento forgiato in maniera sublime da una tradizione secolare ha trovato in Gadda il vertice, lo scrittore in grado di entrare nell’empireo dei grandi del novecento europeo. Quando si ragiona intorno al suo stile subentra un riflesso pavloviano per il quale si pensa al difficile, al complesso e persino all’illeggibile.
Lo stile di Gadda era meravigliosamente difficile, immenso, arabescato, aulico. Ma anche colloquiale, neologistico, tecnicizzante, burocratico, aperto al dialetto e ai forestierismi. Leggendo “Il Pasticciaccio” o “La cognizione del dolore” si viene irrimediabilmente avvinti dalle volute della sua prosa, dalla possente meccanica o finanche ingegneria su cui si regge il tessuto narrativo. Talvolta la prosa gaddiana si fa viva, sembra avvertire il momento in cui il lettore si smarrisce, allora si distende, si fa piana, amica e sorella. Una confidente che ci ascolta e, dopo, ci prende per mano e ci porta via con sé. È ad un tempo profonda ed illuminante, statica e cinematografica. Il lessico ricchissimo ci coinvolge senza scampo alcuno. Fa vedere, toccare, sentire, assaporare le vicende con i sensi dei protagonisti. Il lettore si muove sulla scena della storia narrata come un attore, divenendo egli stesso protagonista. Il continuo ricorso a solecismi, arcaismi e locuzioni dialettali ha caratterizzato l’essenza del suo stile. La capacità di far emergere le stratificazioni della nostra lingua fornì, al critico e filologo Gianfranco Contini, il materiale per giungere al conio della “funzione Gadda”.
Questa asettica definizione rappresenta l’universalità del suo linguaggio, capace di toccare trasversalmente tutte le “vite” della nostra lingua. Vi sono pagine di stupefacente bellezza estetica, cariche di tensione e votate ad un lirismo difficilmente eguagliabile.
La “Cognizione del dolore” presenta quelle che più mi hanno affascinato, scosso ed emozionato. Le riporto per consentirvi di cogliere l’insita grandezza, non parlerò della trama che antecede quei momenti, demando tutto alla vostra sensibilità. Le trascrivo dall’originale, quello che segue è l’attacco della seconda parte, i primi due capoversi:
«Vagava, sola, nella casa. Ed erano quei muri, quel rame, tutto ciò che le era rimasto? di una vita. Le avevano precisato il nome, crudele e nero, del monte: dove era caduto: e l’altro, desolatamente sereno, della terra dove lo avevano portato e dimesso col volto ridonato alla pace e alla dimenticanza, priva di ogni risposta, per sempre. Il figlio che le aveva sorriso, brevi primavere! Che così dolcemente, passionatamente, l’aveva carezzata, baciata. Dopo un anno, a Pastrufazio, un sottufficiale d’arma le si era presentato con un diploma, le aveva consegnato un libercolo, pregandola di voler apporre la sua firma su di un altro brogliaccio : e in così dire le aveva porto una matita copiativa. Prima le aveva chiesto: “è lei la signora Elisabetta Francois?”. Impallidendo all’udir pronunziare il suo nome, che era il nome dello strazio, aveva risposto: “sì, sono io”. Tremando, come al feroce rincrudire di una condanna. A cui, dopo il primo grido orribile, la buia voce dell’eternità la seguitava a chiamare. Avanti che se ne andasse, quando con un tintinnare della catenella raccolse a se, dopo il registro, anche la spada luccicante, ella gli aveva detto come a trattenerlo: “posso offrirle un bicchiere di Nevado?”: stringendo l’una nell’altra le mani scarne. Ma quello non volle accettare. Le era parso che somigliasse stranamente a chi aveva occupato il fulgore breve del tempo: del consumato tempo. I battiti glielo dicevano: e senti di dover riamare, con un tremito dei labbri, la riapparita presenza: ma sapeva bene che nessuno, nessuno mai, ritorna».
Quelli che seguono sono i due capoversi finali:
«Lasciamola tranquilla”, disse il dottore, “andate, uscite”. Nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si dovette raccogliere tumefatto, come in un estremo ricupero della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana coscienza della impossibilità di dire: Io. L’ausilio dell’arte medica, lenimento, pezzuole, dissimulò in parte l’orrore. Si udiva il residuo d’acqua e alcool delle pezzuole strizzate ricadere gocciolando nella bacinella. E alle stecche delle persiane già l’alba. Il gallo, improvvisamente, la suscitò dai monti lontani, perentorio ed ignaro, come ogni volta. La invitava ad accedere e ad elencare i gelsi, nella solitudine della campagna apparita.
Giuseppe Cetorelli