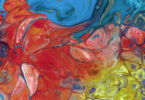Forse s’avess’io l’ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei,
candida luna.
“Corri!, corri Giacomo!”, avremmo sentito risuonare proprio queste parole nel cortile di palazzo Recanati. La dolce e flebile voce di Paolina le avrebbe pronunciate con entusiasmo e passione.
Proprio così, il giovane Giacomo Leopardi era felice al principio della sua vita, divertimenti e giochi scandivano le sue giornate fluide, come quelle di tutti i bambini. Fluidi erano i giochi, liberi, leggeri, come i suoi pensieri. I suoi fratelli erano i fedeli compagni di scorribande festose, sotto lo sguardo vigile di papà Monaldo e mamma Adelaide. La famiglia Leopardi avrebbe potuto essere molto numerosa se le morti precoci non fossero intervenute.
Giacomo, Paolina e Carlo vissero la primissima giovinezza fra gli agi di una famiglia benestante, immersi in una realtà agreste, tra le fisime di genitori avvinti al più oscurantista dogmatismo ecclesiastico. Era il 1798 quando Giacomo aprì gli occhi per la prima volta, in fasce non sapeva cosa la vita gli avrebbe tenuto in serbo, non sapeva che avrebbe portato la croce di un’esistenza angosciosa e sventurata, non era consapevole del genio immenso che gli era stato donato. Questa consapevolezza forse non l’ebbe mai, sino alla fine dei suoi giorni, disteso su di un letto a Napoli, la sua ultima città.
I suoi fratelli erano poco più giovani e crebbero in perfetta simbiosi con il genio di casa. L’infanzia fu certamente lieta, la marchigiana Recanati era tranquilla, anche se l’odor di incenso promanava ovunque, non soltanto dalle chiese. Ben presto però l’aristocratico palazzo Recanati divenne una prigione dorata per i tre fratelli. Quando venne il tempo degli studi, Monaldo decise di mettere a disposizione la ricchissima biblioteca domestica, composta da circa ventimila volumi accumulati da accanito bibliofilo. La sesquipedale cultura dei fratelli Leopardi deve tutto, o quasi, alla clausura di quelle pareti imbottite di libri: teologia, filosofia, filologia, letteratura greca e latina, poesia, persino botanica, i classici dell’epoca e anche qualche libro proibito del settecento francese (J.J Rousseau e gli altri enciclopedisti).
La vita di Leopardi si consumò tremendamente in sette anni di studio matto e disperatissimo. Studiava sullo scrittoio personale, a letto, mentre passeggiava, sacrificava molte ore di sonno allo studio, al debole lume di una candela. Presto ne seppe più lui di qualsiasi precettore, imparò quasi tutto da solo: il greco, il latino, l’inglese, il francese, lo spagnolo e persino l’yiddish non sfuggì alla sua feroce curiosità. Si distraeva soltanto scrivendo lettere ad alcuni letterati dell’epoca, tra cui Pietro Giordani per il quale provò grande ammirazione e divenne suo confidente.
Questo grande poeta fu anche un poderoso pensatore, un filosofo profondissimo che nel primo Ottocento già introduceva argomenti di matrice esistenzialista, prendendo le mosse dalla filosofia stoica e dal pensiero di Blaise Pascal, la cui lettura fu estremamente importante, anche se rimase persuaso della nullità delle cose dopo questa unica vita. Per Leopardi la vita è tutta qui sulla Terra e la morte è la fine ultima oltre la quale v’è il nulla, ossia l’assoluto.
Tra le sue innumerevoli traduzioni c’è anche il Manuale di Epitteto, seguace dello stoicismo, il cui studio lo portò ad assumere un atteggiamento di estrema sopportazione nei confronti dei mali della sua vita. Ecco, le malattie che lo affliggevano non erano solo di natura psicologica (psicosi maniaco-depressiva). Poteva vantare un ampio sistema di patologie, le une legate alle altre. Su tutte la tubercolosi ossea, la quale non tardò a manifestarsi: bloccò la sua crescita a un metro e quaranta, deformò la spina dorsale generando due gobbe, lo ridusse a una semicecità e minò senza scampo la sua salute.
Dalle finestre della sua camera osservava il cielo e gli sembrava di volare, la sua immensa anima voleva uscire da quel corpo deforme e ingeneroso. La sua intelligenza era capace di abbracciare qualsiasi cosa, di comprendere tutto, di conoscere tutto. Divenne uno scrittore diluviale, era il solo modo di uscire da Recanati e liberarsi da quella carcassa. Rese omaggio alla poesia diventando il poeta più importante dell’Ottocento, da questo punto di vista la pensava come Aristotele (Poetica): la poesia è superiore alla storia, poiché racchiude l’assoluto e ci narra l’in-sé delle cose.
I canti rappresentano l’apice del suo lirismo, vi tratta i temi più significativi della sua attività intellettuale – questioni politiche, sociali, di costume e d’arte – da All’Italia ad Aspasia, dal Canto notturno di un pastore errante dell’Asia passando per A Silvia, sino ad arrivare all’Infinito.
La sovrana grandezza del suo Infinito si staglia come un monumento dell’anima, scritto nel 1819 è l’emblema della sua tensione verso l’assoluto, del suo ragionare sull’esistenza degli uomini, un tentativo volto ad esorcizzare la terribilità della nostra finitudine e dissipare la paura più grande. La facoltà di osservare i paesaggi dell’anima, di gettare lo sguardo nelle profondità dell’animo umano e scorgere gli interminati spazi e i sovrumani silenzi, fanno di Leopardi una delle più grandi menti dell’umanità. Le operette morali sono l’opera più filosofica e speculativa. I temi sono quelli cari al poeta: il rapporto dell’uomo con la storia, con i suoi simili ed in particolare con la natura di cui Leopardi matura una personale visione filosofica; il confronto tra i valori del passato e la situazione statica e degenerata del presente; la potenza delle illusioni, la gloria e la noia. Lo Zibaldone di pensieri invece è un’opera lunghissima, multiforme, un insieme di scritti che coprono il periodo che va del 1817 al 1832, lo scritto occupa più di quattromilacinquecento pagine. L’intento fu quello di creare un’opera che potesse ambire ad una certa unitarietà, ma come i Pensieri di Pascal rimase un libro inclassificabile e meravigliosamente incompiuto.
Negli anni le sofferenze di Leopardi furono tremende, per via delle malattie che si accumulavano e accanivano. Cercò anche di fuggire da Recanati poiché non voleva fare come Kant, altra grande mente, che nacque e morì a Koningsberg. Si recò a Roma, poi Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Pisa, fece ritorno a Recanati per approdare a Napoli assieme al suo inseparabile amico Antonio Ranieri. La figura del giovane Ranieri è interessante poiché, stante l’enorme diversità dei caratteri, si prese cura di Leopardi come fosse un figlio. Percorse il viale del tramonto, quel viale che ormai era solo di Giacomo, stringendogli la mano e amandolo autenticamente. Sussurrandogli grazie Giacomo per essere stato “mio”, grazie per essere apparso come folgore che rischiara la tenebra.
Giacomo Leopardi morì il 14 giugno 1837 a Napoli. La sua attività speculativa ha ispirato quella che sarà la filosofia di Nietzsche e prese le mosse da Schopenhauer. Il suo perpetuo circuito di produzione e distruzione degli enti, delle cose e del mondo, è la placenta da cui germinerà l’eterno ritorno di tutte le cose.
Giuseppe Cetorelli