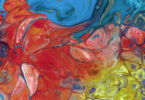Esplorare la mente di uno scrittore può essere un viaggio faticoso e meraviglioso, navigare in un mare invisibile ma assordante. L’interiore che si fa materia attraverso centinaia di pagine grondanti emozioni; la mente che capta le vibrazioni di panorami impossibili da scorgere con gli occhi del corpo. Il pensiero che segue quello di altri tentando di coglierne le scaturigini. L’esplosione semantica che arriva dopo, come una specie di amalgama del pensato.
In questo breve scritto mi accingo a parlare di uno scrittore altissimo, oggi riconosciuto come grande genio della letteratura planetaria. Jorge Louis Borges nacque il 24 agosto 1899 a Buenos Aires, in quell’enorme paese che è l’Argentina la sua mente crebbe nutrita dalle immagini di sofferenza della sua gente, il dolore provocato da guerre e povertà lo avvertì attraverso una sensibilità fuori dal comune, da figlio della classe agiata non indifferente alle miserie dei meno fortunati. Il suo carattere placido e la sua viva intelligenza non tardarono a rivelarsi, da bambino scoprì il piacere della lettura e da qual momento la sua vita cambiò.
Mentre al di là delle sue persiane infuriava una dura realtà sociale, leggeva avidamente i classici e i suoi idoli erano Shelley, Keats, Swinburne. Per la filosofia Berkeley, Hume, Royce e William James.
“Possedeva la bontà e la calma degli uomini intelligenti…”, dicevano di lui conoscenti e amici. Sempre cordiale usava le parole come farmaco, parole di nostalgia spesso. Un velo di dolce melanconia è una delle cifre caratteristiche della sua espressività, la classica semplicità della lingua di Borges è una conquista da lui fatta progressivamente nel corpo del codice spagnolo. Non appena ebbe coscienza della sua vocazione letteraria, ebbe anche coscienza che il suo destino era quello di uno scrittore argentino di lingua spagnola e le sue parole sono in possesso di un alto grado di precisione e allusione.
Le opere di Borges hanno il potere di trascinare in una dimensione atemporale: il tempo cronologico svanisce e quello soggettivo prende il sopravvento, ed è come se tornassimo bambini e un maestro ci prendesse per mano insegnandoci che la vita non finisce dove i nostri occhi terminano di vedere. Solo con Proust mi è capitato di essere così assorbito, fagocitato, intrappolato nelle maglie di una rete letteraria intarsiata di gemme semantiche, le parole di cui fa uso sublime. Sono esse le protagoniste delle sue pagine, avvolte in dense metafore, audaci ossimori e sorprendenti ipallagi. La sua letteratura non solo ha radici nella letteratura (Come gli uomini nascono da altri uomini, la poesia nasce dalla poesia), ma anche nelle strutture sintattiche e retoriche. Il vertice spetta ai racconti, di cui fu maestro inarrivabile.
Finzioni è una raccolta di otto racconti, opera che reca tutti i segni distintivi della letteratura borgesiana. Il nucleo da cui si dipartono le idee è la commozione, il miracolo di scorgere le stratificazioni del reale, un occhio capace di sfogliare l’esistente facendone emergere l’insita bellezza: “C’è un ora della sera in cui le cose sembra stiano per dirci il loro segreto; non lo dicono mai però, o forse lo dicono all’infinito e non lo intendiamo o lo intendiamo, ma è intraducibile come una musica…”, scrive in un suo racconto. Sono allusive metafore di archetipi, sogni di sogni, memorie di memorie, la meraviglia del pensiero.
Agiscono, questi racconti, solo nel momento in cui vengono letti, quasi esemplificando la indispensabilità del lettore perché si produca, di volta in volta, il fatto estetico parzialmente proposto dall’autore. La pagina di Borges si riceve come una esperienza sempre inconclusa e inesaurita perché ripetibile ex novo. Ogni pagina accade per la prima volta ad ogni rilettura, scritta per la scoperta, l’oblio e la riscoperta. Non esiste il tedio del già visto, ma solo panorami nuovi:
“…La sera era intima, infinita. Il sentiero scendeva e si biforcava, tra i campi già confusi. Una musica acuta e come sillabica s’avvicinava e s’allontanava nel va e vieni del vento, appannata di foglie e di distanza. Pensai che un uomo può esser nemico di altri uomini, di altri momenti di altri uomini, ma non di un paese: non di lucciole, di parole, di giardini, di corsi d’acqua, di tramonti.” – Il giardino dei sentieri che si biforcano – Finzioni.
Nella vita di Borges la filosofia ha una parte importantissima, accanto all’ammirazione per i giganti della letteratura come Dostoevskij, Kafka e Proust vi è quella per i pensatori tedeschi come Stirner, Schopenhauer e Nietzsche. L’influenza maggiore la ricevette dal secondo, mutuandone concetti come il mondo proiezione del pensiero, l’impossibilità di rappresentare il soprannaturale, l’arte come unica via per raggiungere un significato, la negazione del tempo e della personalità individuale. Temi che caratterizzano molte sue pagine.
L’amore per la filosofia nacque da esigenze che potremmo definire personali, folgorato da Eschilo quando affermò che “la filosofia è nata avendo come scopo quello di cacciar via con verità il dolore dalla mente, il dolore che rende folli”. Quello che ha sempre affascinato l’intelligenza di Borges è il destino umano e l’eternità. Gli argomenti frequentati riguardano il tempo, la memoria, la fantasia, il labirinto, gli scacchi, luoghi dove l’anima può trovare il suo usbergo.
Democrito è il filosofo antico che gli insegnò a vedere con gli occhi dell’anima, colpito dalla medesima cecità progressiva comprese che la vista può spegnere la visione. Mentre gli occhi della carne osservano la finitudine delle cose, quelli dell’anima possono scorgere l’eternità.
Il grande scrittore argentino si spense a Ginevra all’età di 86 anni. Scrisse sino alla fine, senza stancarsi. Un ultima ed estrema curiosità lo tormentava: vedere cose c’è dopo. Vi regalo la sua voce attraverso una poesia: “Le monete, il bastone, il portachiavi / la pronta serratura, i tardi appunti / che non potranno leggere i miei scarsi giorni / le carte da giunco e gli scacchi / un libro e tra le pagine appassita la viola, monumento d’una sera / di certo inobliabile e obliata / il rosso specchio a occidente in cui arde illusoria un’aurora. Quante cose, atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi / ci servono come taciti schiavi / senza sguardo, stranamente segrete / Dureranno più in là del nostro oblio / non sapran mai che ce ne siamo andati”.
Giuseppe Cetorelli