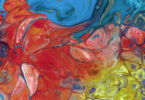Secondo Telesio albus viene impiegato al posto di pallidus perché si diviene bianchi per la paura. Giunto in fondo agli inferi, Dante non trova le fiamme: i traditori stanno confitti nel ghiaccio. L’imbuto infernale concepito da Dante è una distesa gelata, il candore del ghiaccio è un riflesso dell’orrore, lo strumento attraverso il quale si narra l’indicibile. Ma l’inenarrabile può essere testimoniato solo attraverso una lenta assimilazione, dopo essersi salvati, essere tornati a casa dopo tanto peregrinare.
Scorgere la luce accecante della vita nel fondo di una strada buia, come nelle opere di Edward Hopper, dove l’oscurità della tragedia viene interrotta da una luce forte e misteriosa ad un tempo. Varlam Salamov non credeva in Dio, ma le strade che la vita gli ha imposto di percorrere lo hanno avvicinato all’inferno, lo hanno trascinato in un inferno terreno.
Scrittore dal talento straordinario e altissimo, ebbe in sorte di vivere e raccontare uno degli orrori più intensi e più vasti che l’umanità abbia escogitato. I Gulag staliniani, nei quali fu rinchiuso per circa venti anni, sono lo scenario in cui si muovono i personaggi dei suoi racconti.
I racconti della Kolyma, capolavoro assoluto della letteratura novecentesca, rappresentano una vera e propria epopea dell’umano, da una terra gelida e insanguinata Salamov è tornato per narrare l’orrore e le profondità dell’abiezione. Su di lui è gravato un destino e una responsabilità, ed è forse per questo che è scampato alla morte: qualcuno doveva raccontare, descrivere ciò di cui è capace l’uomo. È stato testimone non solo della morte di molti, ma della privazione della dignità, la soppressione di tutte le peculiarità che rendono l’uomo un essere umano.
Sopravvivere alla realtà concentrazionaria dei Gulag significa morire restando in vita.
Varlam nacque nel 1907 a Vologda, suo padre era un prete ortodosso e sua madre un’insegnante, frequentò le scuole superiori con profitto diplomandosi nel 1923. A Mosca, dal 1924 lavorò per due anni come conciatore; si iscrisse poi alla facoltà di Diritto Sovietico ma continuò a coltivare il suo vivo, precoce interesse per la letteratura.
L’arco della sua vita coincide con l’avvento dello stalinismo, passando per la Rivoluzione d’ottobre del 1917.
Il 19 febbraio 1929 fu arrestato per aver diffuso la “Lettera al Congresso” di Lenin e condannato a tre anni di reclusione in un campo di concentramento degli Urali Settentrionali. Nel 1932 tornò a Mosca. Sei anni più tardi comparve sulla rivista “Oktjabr” il suo primo racconto. La notte tra il 1936 e il 1937 fu nuovamente arrestato – “per attività controrivoluzionaria trockista”– e condannato a cinque anni di lavori forzati nelle miniere della Kolyma, la vasta e impervia regione che il fiume omonimo attraversa prima di sfociare nel Mare Siberiano Orientale.
Nel 1942 la condanna gli venne prolungata fino alla fine della guerra; l’anno seguente, questa volta per aver sostenuto che Bunin era un classico russo, venne condannato ad altri dieci anni nell’inferno della Kolyma. Ma la Kolyma, ha scritto Geller, non era un inferno. Era un’industria sovietica, una fabbrica che dava al paese oro, carbone, stagno, uranio, nutrendo la terra di cadaveri.
Come tutti i grandi narratori dell’orrore, Salamov ci porta nei luoghi della sofferenza, la forza della letteratura è quella di trasformarli in cattedrali del dolore rese accessibili dalla scrittura.
L’inaudito si fa parola che colpisce le coscienze, ferisce i cuori, illumina i volti oscuri dell’uomo. Dopo la lettura dei racconti si comprende che nella storia ci sono epoche che sono riuscite a far dimenticare all’uomo che è un essere umano.
Questa storia è vicina a noi, figlia del XX secolo. Varlam Salamov è come un vecchio nonno che ci prende per mano e cerca di insegnarci la vita attraverso la sua vicenda personale, senza presunzione né pedanteria, descrivendo i fatti come si sono svolti. Il dolore che trasuda dalle sue parole non è quasi mai intriso di rancore, semmai disillusione nei confronti della natura umana.
Si prende coscienza che i limiti etico – morali dell’uomo sono più stretti di quello che crediamo. “L’ esperienza di Salamov nei lager”, ha testimoniato Solzenicyn autore di Arcipelago Gulag, “è stata più amara e più lunga della mia, e con rispetto riconosco che proprio a lui e non a me è stato dato in sorte di toccare il fondo di abbrutimento e disperazione verso cui ci spingeva tutta l’esistenza quotidiana nei lager”.
Per un reduce della Kolyma anche un gatto vivo era assurdo, impensabile. “L’essenziale”, diceva Salamov, “non e qui ma nella corruzione della mente e del cuore, quando giorno dopo giorno l’immensa maggioranza delle persone capisce sempre più chiaramente che in fin dei conti si può vivere senza carne, senza zucchero, senza abiti, senza scarpe, corpi seminudi esposti a 40-50 gradi sotto zero, ma anche senza onore, senza coscienza, senza amore né senso del dovere. Tutto viene a nudo, e l’ultimo denudamento è tremendo. La mente sconvolta, già attaccata dalla follia, si aggrappa all’idea di “salvare la vita” grazie al geniale sistema di ricompense e sanzioni che le viene proposto. Questo sistema è stato concepito in modo empirico, giacché impossibile credere all’esistenza di un genio capace di inventarlo da solo e d’un sol colpo… Perdonatemi se vi parlo di cose così tristi ma vorrei che aveste un’idea più o meno corretta di questo fenomeno capitale e singolare che ha fatto la gloria di quasi venti anni di piani quinquennali e dei grandi cantieri che vengono definiti audaci realizzazioni”.
Liberato dal lager nel 1951, lo scrittore potè tornare a Mosca solo nel dicembre 1953 e per due giorni soltanto. Nella capitale rivide la moglie e la figlia, da cui era però destinato ad essere diviso per sempre; incontrò Boris Pasternak (autore del romanzo Il dottor Živago), con cui era entrato in corrispondenza nel marzo del 1952. Stabilitosi nella regione del Kalinin, iniziò a scrivere I racconti della Kolyma. Nel luglio 1956, riabilitato, poté far ritorno nella capitale.
Dal 1961 al 1967 videro la luce tre sue raccolte di poesie, ma i racconti sulla Kolyma gli venivano puntualmente restituiti dalle redazioni di riviste e case editrici. Altrettanto dolore provocò in lui il destino dei suoi racconti all’estero, dove per lunghi anni vennero pubblicati in modo sparso e frammentario, secondo approssimativi criteri filologici.
L’interesse che l’Occidente manifestò per la sconvolgente testimonianza artistica di Salamov impensierì le autorità sovietiche, che nel 1972 costrinsero lo scrittore in disgrazia a sconfessare I Racconti della Kolyma, imponendogli la definizione di opera puramente inventata, con un documento in cui tra l’altro affermava che “la loro problematica era stata superata dalla vita”, dal XX Congresso del PCUS.
Gravemente provato nel fisico dagli anni di lager e nello spirito dagli anni di “libertà”, Salamov non smise mai di scrivere. Nel 1973 terminò il lavoro sulla vasta e agghiacciante epopea della Kolyma, che si compone dei “libri” I Racconti della Kolyma, titolo divenuto canonico per l’intero corpus di scritti, La riva sinistra, Il virtuoso della vanga, Schizzi dal mondo criminale, La resurrezione del larice, Il guanto, ovvero KR-2.
Quando morì, nel 1982, l’opinione pubblica si domandò come fosse riuscito a vivere 75 anni, dopo gli orrori attraversati. Forse a questa domanda si può rispondere che non poteva morire prima di aver compiuto la sua missione di testimone vivente.
Ed ora vi porto nel Gulag della Kolyma, citando il breve racconto d’esordio, in quella che è stata la sua “casa” per un ventennio: “Come viene aperta una strada nella neve vergine? Un uomo avanza per primo, sudando e imprecando, muove con difficoltà una gamba poi l’altra, e sprofonda ad ogni passo nello spesso manto cedevole. L’uomo è sempre più lontano e nere buche irregolari segnano il suo cammino. Stanco, si allunga sulla neve, accende una sigaretta e il fumo della machorka si espande lentamente in una piccola nuvola azzurrina sopra la bianca neve scintillante. L’uomo è già andato oltre, ma la nuvoletta resta sospesa là dove si era fermato a riposare: l’aria è quasi immobile. Per aprire una strada si scelgono sempre delle giornate calme, affinché i venti non spazzino via le opere degli uomini. L’uomo sceglie da sé i punti di riferimento nell’infinità nevosa: una roccia, un albero alto, e come il timoniere che conduce la barca lungo il fiume, da un promontorio all’altro, cosi l’uomo sposta il suo corpo attraverso la neve. Sulla pista stretta e labile che ha segnato avanzano, spalla contro spalla, cinque o sei uomini. Tutti posano il piede non nella traccia ma accanto ad essa. Quando raggiungono un punto convenuto in precedenza, fanno dietro front e ritornano sui propri passi, sempre badando a calpestare la neve intatta, là dove l’uomo non ha ancora posato il suo piede. La via è tracciata. Altre persone, e slitte e trattori possono percorrerla. Se si camminasse, passo dopo passo, nella traccia del primo, si otterrebbe un cammino visibile ma stretto e a stento praticabile, un sentiero e non una strada, delle buche nelle quali arrancare ancora più faticosamente che nella neve vergine. Per il primo la fatica è maggiore che per tutti gli altri e quando non ce la fa più uno del quintetto di testa passa avanti. Ognuno di quelli che seguono la traccia, anche il più piccolo, il più debole, deve posare il piede su di un lembo di neve vergine e non nella traccia di un altro. Quanto ai trattori e ai cavalli, non sono per gli scrittori, ma per i lettori.”
Giuseppe Cetorelli